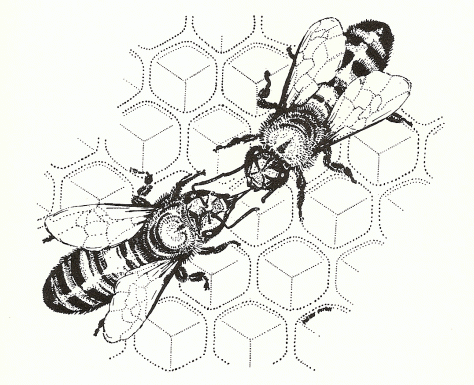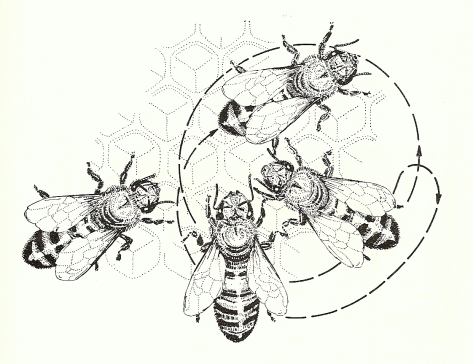Il ciclo di vita, le abitudini e le produzioni di regina, operaia e fuchi.Le api vivono in colonie composte normalmente da una sola ape regina, da diverse migliaia di api operaie (fino a 60-70.000) e da alcune centinaia di maschi (o fuchi). L’ape regina è un individuo di sesso femminile, originatosi da un uovo fecondato; è l’ape più grande dell’alveare con un addome allungato adatto a contenere gli ovari molto sviluppati. Svolge unicamente la funzione di riproduzione. Nello svolgimento di questo compito è seguita da un gruppo di operaie che la nutrono e la accudiscono. L’ape operaia è un individuo di sesso femminile originatosi da un uovo fecondato, ma sterile non avendo sviluppato gli ovari. Le api operaie sono addette a svolgere tutti i lavori necessari al buon sviluppo della colonia. Nell’ambito delle diverse sottospecie si trovano delle eccezioni: le operaie di A. m. capensis, in caso di orfanità della famiglia, possono deporre uova diploidi dalle quali si originano delle regine. Il fuco è un individuo di sesso maschile, originatosi da un uovo non fecondato. È presente negli alveari soltanto durante le bella stagione avendo come funzione principale quella di accoppiarsi con le nuove regine. Una famiglia di api risulta mediamente composta da una sola ape regina, da 20 a 60000 api operaie e da alcune centinaia di fuchi. La regina non ha il comando dell’alveare; essa svolge unicamente le funzioni di riproduttice e ovifica costantemente per mantenere numerosa e efficiente la colonia. E’ sempre circondata da un seguito di operaie che la nutrono, accudiscono e la proteggono. Le api operaie si procurano il cibo all’esterno e si occupano di tutti i lavori interni per mantenere in efficienza il nido. Non sono suddite della regina, ma, si può dire che l’insieme di tutti gli individui rappresentino quasi un unico organismo. Il fuco non presta alcuna opera all’interno del nido ma viene tollerato perché è necessario per l’inseminazione della regina. E’ necessaria la presenza di un buon numero di fuchi perché la regina possa essere inseminata da un maschio forte e sano, per dar vita ad una colonia solida, stabile e produttiva. Ciclo di vita Una famiglia di api è composta da una sola femmina feconda (la regina) da un certo numero di maschi e da molte femmine sterili, destinate al lavoro interno all’alveare e a procurare il cibo. La regina dopo essere ritornata dal volo di accoppiamento inizia la deposizione delle uova, dalle quali nasceranno, se fecondate, api femmine che si occuperanno dell’alimentazione e della cura del nido, oppure maschi da uova non fecondate. Regina
Le maggiori dimensioni rispetto alle api operaie sono dovute essenzialmente alla diversa dimensione dell’addome. Inoltre, rispetto all’operaia, ha zampe prive di cestelle per il polline, ligula molto corta, pungiglione dotato di un minor numero di uncini. Le regine hanno origine da un uovo fecondato e, normalmente si sviluppano in apposite celle, allungate, disposte in verticale generalmente sul bordo dei favi, i cui abbozzi sono generalmente conosciuti come cupolini reali. In caso di morte improvvisa della regina le operaie possono allevare una o più regine di sostituzione a partire da uova o giovani larve (perché di età inferiore a tre giorni) che si trovano nelle cellette da operaia. Dopo tre giorni dalla deposizione, terminata fa fase embrionale, si ha lo sgusciamento della larva che viene nutrita con dosi sovrabbondanti di gelatina reale (o pappa reale). Passando attraverso lo sviluppo larvale (sei giorni e mezzo circa) e la fase di pre-pupa e di pupa (sei giorni e mezzo circa), si ha il completamento dello sviluppo e lo farfallamento che avviene dopo aver eseguito il taglio dell’opercolo. Poiché le api, per garantirsi la prosecuzione della specie, allevano più regine, la prima nata cerca tra i favi le regine non ancora nate e le trafigge con il pungiglione. Alcune volte questo fenomeno non avviene e, pertanto, possono aversi uno o più sciami secondari. Dopo cinque/sei giorni dalla nascita, nelle ore più calde, la regina esce dall’alveare per i voli di accoppiamento. Inseguita in volo dai fuchi subirà numerosi accoppiamenti. I fuchi più vigorosi che riusciranno a raggiungerla e ad accoppiarsi in seguito moriranno, a causa delle lesioni riportate dall’endofallo nella fase di distacco dalla regina. Durante questi ripetuti accoppiamenti la regina riceverà circa 80-90 milioni di spermatozoi, accumulati negli ovidotti laterali; nelle successive 24 ore la maggior parte degli spermatozoi saranno espulsi e solo il 10% circa migreranno nella spermateca. Qualora l’accoppiamento delle regine evvenga dopo 15-16 giorni dalla nascita, per esempio a causa di condizioni meteorologiche avverse, non si ottengono delle buone riproduttrici e le colonie che ne derivano sono normalmente mediocri. A seguito dei voli di accoppiamento si ha l’ingrossamento degli ovari della regina e la stessa inizia a deporre le uova dopo tre o quattro giorni. La deposizione dell’uovo è preceduta da un accurato lavoro di pulizia della cella a cura delle api operaie, le quali seguono la regina, la nutrono e la proteggono. Nell’epoca di maggior attività la regina depone dalle 1.000 alle 2.000 uova al giorno e talvolta può arrivare a 3.000. La deposizione inizia sempre nella zona centrale del glomere allargandosi via via, a spirale sui diversi favi, in dipendenza della capacità della colonia di garantire le condizioni di termoregolazione del nido ottimali per lo sviluppo della covata (35 °C circa). L’aspettativa di vita di una regina è di cinque anni e per questo motivo è stata definita, a livello internazionale, una serie di cinque colori che possono essere utilizzati per contrassegnarla; a partire dagli anni che iniziano con lo zero o con il cinque si utilizzano successivamente: azzurro, bianco, giallo, verde, rosso. Il massimo rendimento delle regine si ha nei primi due anni mentre al terzo anno solo il 30% circa mantiene una buona efficienza di deposizione. A causa di questo naturale calo di efficienza, qualora si desideri avere alveari fortemente produttivi, è necessario sostituire sistematicamente le regine. Operaia Le dimensioni delle api operaie differiscono secondo le diverse sottospecie. Le api che si Le api operaie hanno origine dalle uova fecondate, deposte dalla regina; le uova sono di forma allungata con le due estremità arrotondate (circa 1,5 mm per 0,3-0,4 mm), di colore bianco perlaceo. E’ possibile conoscere l’età dell’uovo osservandone la posizione nella celletta: in posizione verticale se di un giorno, in posizione obliqua se di due giorni, adagiato sul fondo della celletta, in posizione orizzontale, al terzo giorno. Al quarto giorno, terminata l’embriogenesi, sgusciano le larve che vengono alimentate dalle giovani operaie nutrici con il secreto delle ghiandole ipofaringee e mandibolari per i primi tre giorni (questo alimento differisce per composizione dalla gelatina reale destinata alle larve di regina). A partire dal quarto giorno di vita larvale le larve subiscono un cambio di alimentazione, a base di miele e polline, fatto che impedisce lo sviluppo degli ovari. La larva si sviluppa rapidamente e, passando attraverso cinque mute, e la fase di eopupa, si trasforma successivamente in pupa. Al decimo giorno dalla deposizione, corrispondente alla fase di passaggio a eopupa, mentre le larve filano il bozzolo, le operaie chiudono le cellette con un opercolo permeabile all’aria. Durante la fase di pupa si ha la formazione degli organi interni e il corpo dell’ape assume la sua forma definitiva. Lo sviluppo preimmaginale si compie in un periodo di tempo di circa 21 giorni al termine dei quali l’ape, rosicchiato l’opercolo, emerge dalla celletta. Le api adulte hanno una aspettativa di vita di circa 40 giorni, durante la bella stagione, e di alcuni mesi nel periodo autunno invernale, in conseguenza della maggiore o minore attività cui le api saranno sottoposte. Potremmo dire che api dell’estate vivono poco perché sottoposte a un lavoro fortemente usurante. Durante la sua vita l’ape operaia assume compiti diversi a seconda dell’età, come riepilogato, a titolo indicativo, nella seguente tabella:
La suddivisione delle diverse fasi di lavoro descritte nella tabella non vengono applicate con rigidità: a seconda delle condizioni esterne e delle necessità contingenti, qualche compito lavorativo può essere saltato e, viceversa, può essere richiesto all’insetto di tornare ad esercitare una attività già svolta in una fase precedente. In caso di squilibrio di una famiglia, ad esempio a seguito di sciamatura, le api operaie possono svolgere funzioni diverse non strettamente legate a quelle tipiche legate all’età anagrafica. Quando una famiglia perde la regina, e non ci sia la possibilità allevarne una di sostituzione, alcune operaie possono sviluppare ovari e deporre uova che, non essendo fecondate, daranno origine solo a maschi; tali operaie vengono chiamate fucaiole. Fuco Ha un corpo di 15 mm di lunghezza, il torace largo circa 5 mm e pesa circa 230 Il fuco si sviluppa in un periodo di 24 giorni a partire da uova non fecondate, all’interno di cellette aventi diametro di 6,2-6,4 mm circa, normalmente realizzate nella periferia dei favi. Dopo lo farfallamento i fuchi vengono nutriti per qualche giorno dalle operaie poi si alimentano da soli con miele prelevato dai favi. La vita del fuco ha una durata di circa 50 giorni. La maturità sessuale si compie dal 12°-14° giorno di età. I fuchi hanno libero accesso in tutti gli alveari. La presenza nell’alveare coincide con il periodo stagionale durante il quale le api possono allevare regine, in quanto la sua funzione è quella di garantirne l’accoppiamento. Quando sono in volo formano dei veri e propri sciami in aree ben definite, dette zone di raduno, all’interno delle quali avvengono gli accoppiamenti. Al termine del periodo della sciamatura o comunque della bella stagione le operaie li scacciano dal nido o li uccidono. Tabella riepilogativa della metamorfosi La seguente tabella riepiloga le principali fasi della metamorfosi dei componenti della famiglia di api. In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli la nascita può ritardare oppure, talvolta, anticipare di un giorno.
Sciamatura naturale La sciamatura naturale è il metodo di propagazione delle famiglie di api; si manifesta con la separazione e l’allontanamento di una parte delle api e della regina della famiglia di origine per dare vita ad un nuovo nucleo. Normalmente l’epoca della sciamatura coincide con l’inizio del raccolto principale: marzo nel sud, aprile o maggio nelle pianure del nord e giugno o luglio in zone montagnose. Essa avviene nel caso sussistano una serie di fattori che rappresentano la normalità di una buona famiglia: colonia numericamente forte e ricca di scorte alimentari, regina sana, forte e produttiva; inoltre incidono sulla sciamatura anche fattori esterni quali la mitezza della temperatura e la disponibilità di un buon raccolto da bottinare. Quando nell’arnia sembra mancare lo spazio per la deposizione della regina, le operaie costruiscono una serie di celle reali (4-10) nelle quali allevano nuove regine. La colonia allora si prepara alla sciamatura intensificando l’importazione di polline; la temperatura interna aumenta, le api sostano nei pressi dell’uscita dell’alveare (fanno la barba) e aumenta la presenza di fuchi. Nel frattempo nell’alveare di origine, dopo qualche giorno nascerà una nuova regina vergine, la quale a sua volta potrà decidere di sciamare, portando con sé un’altra parte della famiglia. In questo caso si avrà uno sciame secondario, a differenza dello sciame primario descritto in precedenza. Successivamente potrà nascere un’altra nuova regina, la quale, a sua volta può dar vita ad un’altra sciamatura detta terziaria. La sciamatura secondaria e terziaria avviene con giovani regine vergini che dovranno essere inseminate una volta raggiunto il nido di destinazione. Essendo più leggere per l’assenza di uova, esse possono percorrere distanze maggiori. La sciamatura naturale, in genere si rivela dannosa per l’apicoltore perché riduce il raccolto principale; essa rappresenta però una buona occasione per incrementare il numero delle famiglie. Un’alta propensione alla sciamatura è comunque considerata una caratteristica negativa della famiglia; l’apicoltore dovrà selezionare regine che non abbiano questo difetto. Volo nuziale La giovane regina vergine, per farsi accettare dalle operaie deve essere feconda. Dopo aver memorizzato i riferimenti per localizzare il proprio nido, esce e si dirige verso l’alto, subito inseguita dai fuchi, del proprio e di altri alveari. La presenza di fuchi di altri alveari riduce i casi di consanguineità fra componenti strettamente imparentati fra di loro, limitandone la frequenza. Il fuco più veloce e più resistente raggiunge la regina e la insemina con il proprio seme; al momento del distacco avviene lo strappo dell’organo maschile, del ventre e delle viscere, che provocheranno la morte del fuco. Il volo nuziale è sempre di breve durata: per evitare i pericoli dovuti alla presenza di molti nemici esterni, la regina tende a ridurre il proprio volo al minimo indispensabile, anche se spesso viene inseminata più di una volta. Dopo alcuni giorni dal/i volo/i nuziale/i, la regina inizierà a deporre in seguito all’accoppiamento fra i propri ovuli e il seme maschile (fecondazione) che ha accumulato nella spermoteca. Gli ovuli fecondati daranno origine a insetti femminili, mentre quelli non fecondi daranno origine a fuchi. La regina continuerà la deposizione e non lascerà più il nido per il resto della propria vita, se non in caso di sciamatura. Uccisione dei fuchi Al termine dell’estate, quando la famiglia ritiene di non aver più bisogno dei maschi riproduttori, provvede a sopprimerli aggredendoli in massa e uccidendoli con il pungiglione e con le mandibole. I maschi, privi di pungiglione sono inermi e possono salvarsi solo con la fuga anche se difficilmente potranno trovare ospitalità in altri alveari (tranne che nel caso di famiglie con regine deboli). Riposo invernale Con il sopraggiungere dell’autunno, la deposizione della regina rallenta e con essa tutte le attività della colonia. Le api bottinatrici iniziano ad incontrare crescenti difficoltà nel procurare il cibo e spesso restano vittime delle condizioni meteorologiche avverse. Con l’irrigidimento della temperatura esterna, le api si raccolgono al centro del nido a ridosso della regina e si riscaldano fra di loro. Verso lo strato più esterno restano le api più vecchie, le quali si spostano periodicamente verso l’interno per riscaldarsi, cedendo il posto a quelle che immediatamente le precedevano. La regina e le api più giovani rimangono più a lungo al centro del glomere e meglio sfruttano la protezione della famiglia. La temperatura nella zona di stazionamento della regina deve rimanere costante fra i 25 e i 30 gradi centigradi; per mantenere questa temperatura le api consumano una grande quantità di miele e, paradossalmente, a causa del maggior dispendio di energia, ad una minore quantità di api corrisponde un maggiore consumo di scorte. Se le scorte sono sufficienti, la famiglia è in grado di superare periodi di freddo intenso anche di lunga durata e sono in grado di sopravvivere anche in condizioni ambientali molto rigide. Il buon apicoltore si accerta che non vi siano correnti e ristagni di umidità, riducendo il numero dei telaini del nido e lo spazio delle porticine d’ingresso, assicurandosi che la famiglia disponga di scorte sufficienti per superare l’inverno. Le scorte devono essere collocate nel punto in cui si forma il glomere (normalmente nel punto più caldo dell’alveare, cioè il punto più soleggiato durante l’inverno); è necessario verificare che i telaini al centro del glomere siano dotati di abbondante quantità di miele nella fascia superiore, per evitare che le api, durante il periodo di freddo più intenso, rimangano senza nutrimento pur avendone a disposizione nei telaini laterali. Alimenti e sostanze elaborate dalle api Le api bottinatrici hanno il compito di procurare gli alimenti e le sostanze necessarie per la vita dell’alveare: principalmente nettare, polline, resine vegetali e acqua. All’interno dell’alveare le api elaborano questi alimenti e producono miele, cera e propoli: il miele viene utilizzato come scorta alimentare, la cera è la materia prima per la costruzione dei favi e la propoli viene utilizzata come disinfettante e sigillante. Nettare e miele Il nettare è una sostanza acquosa e zuccherina che le api raccolgono dai calici dei fiori o dalla base delle foglie delle piante; esso viene secreto con lo scopo di attirare gli insetti pronubi perché collaborino all’impollinazione: prelevando il nettare infatti, le api si imbrattano di polline e lo trasportano di fiore in fiore. Il nettare è costituito principalmente dal 30 al 90% di acqua, dal 15 al 20% di saccarosio, da 10 al 15% di glucosio e fruttosio. La composizione del nettare varia a seconda a seconda della specie, della zona, del clima e anche a seconda del momento della raccolta. Esso viene aspirato dalle api attraverso l’apparato boccale (lingua o proboscide) e accumulato nello stomaco (ingluvie o sacca melaria), all’interno del quale il nettare subisce una prima trasformazione grazie ad una sostanza (invertina) secreta dalle ghiandole dell’ape: il saccarosio viene convertito in glucosio e fruttosio, zuccheri più facilmente assimilabili dalle api. Le api bottinatrici generalmente continuano a visitare la stessa specie botanica sino allo riempimento della sacca melaria. La sacca melaria delle api bottinatrici contiene circa 50/60 milligrammi di nettare e, per essere riempita, richiede la visita di molti fiori; ne consegue che per produrre 1 kg di miele le api devono compiere circa 50.000 voli visitando milioni di fiori. In una giornata di abbondante fioritura situata nei pressi dell’alveare, una famiglia di api può produrre dai 6 ai 10 KG di raccolto. Le api sfruttano la stessa zona situata nel raggio di poche centinaia di metri, allargandosi sempre di più sino a coprire un raggio di 3 km intorno all’alveare. Al ritorno all’alveare l’ape rigurgita il contenuto della sacca melaria nella cella del favo o lo passa ad altre api (trofallassi: lo scambio di cibo fra i diversi individui dell’alveare rappresenta una delle più caratteristiche manifestazioni del comportamento sociale delle api) per favorire l’evaporazione dell’acqua: perché il miele sia maturo e perfettamente conservabile la percentuale di umidità non deve essere superiore al 18%. Per questa ragione le api riempiono gradatamente le cellette, sfruttando la naturale evaporazione del miele e, infine, le opercolano con un sottile coperchietto di cera solo quando esso raggiunge il giusto grado di maturazione. La trasformazione degli zuccheri del miele prosegue anche dopo l’opercolazione (e anche dopo l’eventuale smelatura); il miele tende a stabilizzarsi in una percentuale paritaria di glucosio e fruttosio e da un basso contenuto di saccarosio.
Fig. 1 – La trofallassi. Immagine tratta da “L’Apicoltore Moderno” Università di Torino, Osservatorio di Apicoltura “G. Angeleri”. Manna, secrezione di afidi e melata Oltre che dal nettare dei fiori, le api traggono il loro raccolto dalle melate che ricoprono le piante in determinate condizioni. La melata è un liquido dolciastro di origine vegetale o animale. Il miele prodotto dalla melata è scuro, assai denso e dolciastro e di difficile estrazione. Melata vegetale o manna Durante le calde giornate estive (soprattutto se particolarmente afose e interrotte da un brusco raffreddamento che blocca la circolazione della linfa nelle piante), le foglie delle piante trasudano gocce vegetali zuccherine che l’acqua della rugiada rende talora così fluide da farle cadere al suolo. Questa sostanza, di origine puramente vegetale è detta manna ed è molto gradita dalle api che si premurano di raccoglierla prima che il calore ne faccia evaporare l’umidità ed essa venga riassorbita dalle foglie; essa si trova spesso sui rovi, sul biancospino, su pini, abeti, ontani, olmi, tigli, platani e pioppi, ma anche su piante erbacee. Il miele prodotto dalla manna è assai denso e dolciastro e di difficile estrazione. Melata animale La melata animale è prodotta dalle secrezione di escrementi di afidi (pidocchi) che infestano le piante in particolari annate; è la parte non digerita delle sostanze succhiate dalle piante dagli afidi e si presenta anch’essa in forma di goccioline vischiose e zuccherate, che mantengono il sapore della pianta d’origine; essa si trova spesso su abeti, pini e alberi da frutta. Polline Il polline è un pulviscolo generalmente giallastro, rossastro o bruno prodotto dagli stami per la fecondazione dei fiori. L’ape si posa sul fiore, ne sugge il nettare provocando lo scuotimento degli stami e la caduta del polline, il quale in parte si deposita nell’ovario del fiore e in parte sul corpo dell’ape. Durante la visita di altri fiori, il polline depositatosi sul corpo dell’ape viene a contatto con lo stigma del fiore e quindi scende nell’ovario, dove avviene la fecondazione che darà origine al seme. Le api raccolgono il polline quale nutrimento assai ricco di proteine; la raccolta può avvenire mentre le api suggono il nettare o anche in modo specifico. Con le spazzole di cui sono dotate le zampe posteriori, l’ape raccoglie il polline, lo impasta con la saliva e nettare e ne forma delle palline che sistema nelle cestelle delle zampe. Tornata all’alveare, l’ape depone il polline in una celletta ai lati della covata, servendosi dello sprone. Il polline verrà utilizzato per la preparazione dell’alimento per le covate: si tratta di una pappa lattiginosa costituita da miele, polline ed acqua parzialmente digeriti; essa viene utilizzata per l’allevamento della covata nei primi tre giorni di vita e per l’alimentazione della regina. L’importazione del polline negli alveari avviene soprattutto in primavera, durante la fioritura delle piante fruttifere. La quantità occorrente ad una famiglia di api nel corso dell’anno varia da 25 a 40 Kg, a seconda dell’intensità della covata; è importante che durante l’inverno la famiglia abbia accumulato una buona quantità di polline, per essere pronta ai bisogni alimentari delle prime covate primaverili; in caso di scarsità delle scorte e di assenza di raccolto, l’apicoltore dovrà provvedere con la somministrazione di succedanei, quali farine di cereali o di legumi. Propoli Con la raccolta delle sostanze emanate dalle gemme, dalle pigne e dalle trasudazioni delle piante resinose (pini, abeti, larici, pioppi, betulle , cipressi, faggi, ontani, olmi, ciliegi, querce), le api producono la propoli: una sostanza amara ed aromatica composta da resine (50%), cera (40%) e olio d’essenza (10%). Si presenta inizialmente come morbida, appiccicosa e chiara mentre tende ad indurire e a scurirsi con il passare del tempo; diventa solida e dura a basse temperature. La propoli viene utilizzata dalle api come sigillante e disinfettante; spesso le api se ne servono per avvolgere, isolare e impedire la putrefazione delle carcasse dei nemici morti che non riescono a trasportare all’esterno dell’alveare. Aprendo un’arnia l’apicoltore può constatare che il coprifavo viene sigillato e reso solidale con il nido e che i telaini vengono bloccati per impedirne l’oscillazione.
Fig. 2 – Ape che bottina propoli su gemme di pioppo. Immagine tratta da “L’Apicoltore Moderno” Università di Torino, Osservatorio di Apicoltura “G. Angeleri”. Vedi l’articolo dei prof.i Franco Marletto e Giacomo Olivero tratto da “L’Apicoltore Moderno” Università di Torino, Osservatorio di Apicoltura “G. Angeleri”: Raccolta e utilizzazione della propoli da parte delle api Cera La cera viene prodotta da apposite ghiandole (ghiandole ceraiole) mediante la trasformazione di sostanze zuccherine; ha un colore bianco/giallastro più o meno intenso a seconda delle piante visitate dalle bottinatrici. Viene utilizzata dalle api per la costruzione dei favi (costituiti dal 92-95% di cera pura e per il resto da propoli e polline) e per percolarne le cellette. Vedi l’articolo del dr. Piero Piton tratto da “L’Apicoltore Moderno” Università di Torino, Osservatorio di Apicoltura “G. Angeleri”: Cera d’api Acqua L’acqua rappresenta un elemento fondamentale per la vita dell’alveare: grazie ad essa vengono mantenute le condizioni ottimali di umidità e temperatura necessarie per il corretto sviluppo della covata, in particolare per la schiusa delle uova. Per un buon andamento dell’apiario è necessario che esso sia collocato nelle immediate vicinanze di fonti acquifere, o che l’apicoltore provveda alla fornitura d’acqua collocando un abbeveratoio nei pressi dell’apiario. Linguaggio delle api L’ape bottinatrice, quando trova una buona fonte di cibo, ne comunica ubicazione e quantità alle altre api della famiglia attraverso una particolare comunicazione corporea:
Altri atteggiamenti corporei indicano la presenza di nemici o altre circostanze importanti per la vita della colonia.
Fig. 2 – Schema della danza circolare usata dall’esploratrice per segnalare la presenza di una sorgente di cibo, di acqua o di propoli nelle immediate vicinanze dell’alveare. Immagine tratta da “L’Apicoltore Moderno” Università di Torino, Osservatorio di Apicoltura “G. Angeleri”. |
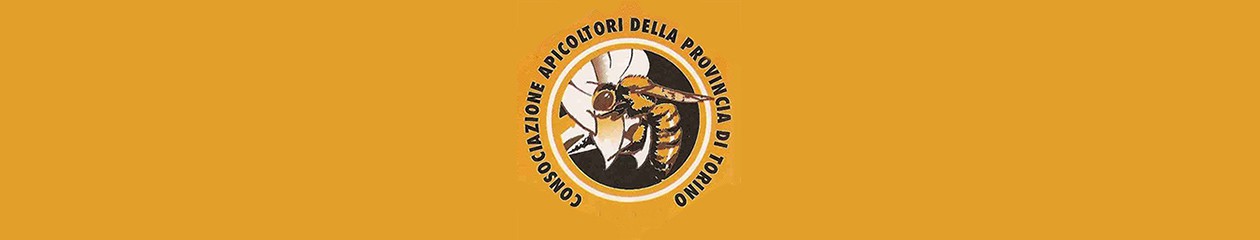


 trovano in Italia hanno un corpo di 12-13 mm di lunghezza, torace largo circa 4 mm e pesano circa 100 milligrammi, un chilogrammo di api mellifere contiene quindi 10.000 api circa. Le zampe dell’operaia sono dotate di pettine, spazzola e cestella per raccogliere il polline.
trovano in Italia hanno un corpo di 12-13 mm di lunghezza, torace largo circa 4 mm e pesano circa 100 milligrammi, un chilogrammo di api mellifere contiene quindi 10.000 api circa. Le zampe dell’operaia sono dotate di pettine, spazzola e cestella per raccogliere il polline. milligrammi.
milligrammi.